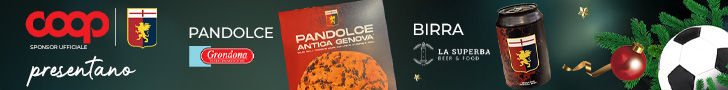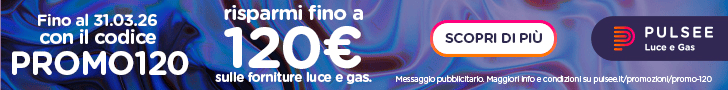La scorsa settimana ero in vacanza in Ogliastra, tra mare e monti sardi. Un pomeriggio mi trovavo in un parco del Supramonte, al fresco con Bondy, il cane, quando mi si avvicina un signore sardo, tifoso del Vecchio Balordo, che segue Buoncalcioatutti e le cronache di Radio Nostalgia. Aveva in mano degli adesivi con scritto: “Riempiamo l’altra gradinata”, che attaccava ovunque. Rimasto sorpreso, gli ho chiesto il perché: semplicemente perché la zona è molto frequentata dai genovesi, e dal 1° luglio c’è il traghetto Genova-Arbatax. Abbiamo parlato di Genoa, del passato, del presente e del futuro, con l’unica soddisfazione della conferma di Vieira e un calciomercato che deve ancora decollare.
Con lui c’era un bambino di nove anni che mi ha fatto una domanda a bruciapelo: “Perché il calcio si gioca in undici contro undici?”. Grazie all’aver letto libri di calcio, ho provato a dare una risposta.
Il calcio è nato nei collegi anglosassoni e, poiché le camerate erano composte da 10 allievi con un tutore responsabile, le gare di calcio e i tornei che si svolgevano all’interno del college prevedevano squadre composte da undici giocatori.
Alla fine del campionato, con Buoncalcioatutti ho cercato di viaggiare parlando di calcio in due editoriali: “Caratteristiche e principi di un sistema di gioco” e “Un trip (viaggio) nella tattica”.
In questo pezzo proverò a fare un riassunto — non una storia troppo lunga — sull’evoluzione, se c’è stata, dei sistemi di gioco. Uno spunto nato dalla sensazione di non vedere grandi cambiamenti rispetto a quanto accadeva negli anni ’50/’60.
Il calcio è nato in Scozia e in Inghilterra. Lo stile era “kick and rush”, cioè calcia e corri: pallone in avanti e tutti dietro a inseguirlo. Il dribbling e il tiro finale facevano la differenza.
Il primo gioco di squadra fu il Sistema Piramidale: portiere, due terzini, tre mediani e cinque attaccanti. Il calcio era votato all’attacco, perché solo il gol era spettacolo.
Siccome, come sempre, qualcuno approfittava per giocare alle spalle della difesa, fu inventata la regola del fuorigioco: per non essere in fuorigioco era necessario avere tre avversari tra sé e la porta, su tutta la lunghezza del campo.
Dopo il Sistema Piramidale nacque la Piramide di Cambridge, per limitare i danni causati dal fuorigioco a tre. Un’impostazione che vediamo ancora oggi, dividendo la squadra in tre linee. Questo sistema, per la prima volta, definì con chiarezza i ruoli in campo.
Il calcio attuale è compreso in questo concetto: 5 difensori e 5 attaccanti. È l’equilibrio che cercano tutti gli allenatori. In questo sistema, ogni tecnico studia dove mettere le ali, cosa far fare ai mediani e alle mezzali.
Ma l’equilibrio non viene dallo schema, bensì dagli uomini. L’equilibrio è il sacrificio di adattare lo schema ai giocatori e viceversa. Senza equilibrio non c’è vero calcio. Ma l’equilibrio da solo non basta per vincere: tocca sempre all’uomo in campo fare la differenza.
La regola del fuorigioco cambiò nuovamente intorno al 1925: da tre avversari su tutto il campo si passò a due nella metà campo avversaria, per migliorare il gioco offensivo. Questo portò a un cambiamento nei sistemi di gioco.
Il primo ad approfittarne fu Herbert Chapman, manager dell’Arsenal, che mise in campo il sistema WM: la Wrappresentava l’attacco, la M la difesa. Un centrocampo a quadrilatero, con due mediani e due mezzali, tre attaccanti (due ali e un centravanti), orientato al passaggio in profondità e alla ricerca di spazi liberi con velocità. (Qualcosa è cambiato oggi? Forse no.)
Il WM in Italia, dove era preferito il gioco d’attesa e contropiede, raggiunse l’apice con il Grande Torino, con Mazzola e Loik in mezzo al campo.
Il WM venne però superato quando l’Inghilterra, padrona dello schema, fu sconfitta a Wembley per 6-3 e a Budapest per 7-1 dall’Ungheria di Puskás, Kocsis e Hidegkuti, falso centravanti.
Il nuovo sistema magiaro, detto MM, prevedeva un centrocampo a cinque, ali che attaccavano e difendevano, gioco corto nelle due fasi e una difesa pronta ad applicare il fuorigioco.
Questi moduli offensivi si scontrarono col catenaccio, o “verrou” in francese: l’idea era infoltire la difesa a scapito dell’attacco. Ancora oggi, la parola “catenaccio” è usata in senso negativo, sostituita da “difesa e ripartenza”.
C’era la marcatura a uomo che impediva agli avversari di giocare, e un fuorigioco attendista.
Servirebbe un libro per raccontare tutto ciò che è successo nel calcio italiano dopo gli anni ’60, senza dimenticare l’influenza del Brasile, dell’Uruguay, dell’Argentina e il calcio totale olandese di Rinus Michels, che ancora oggi molti cercano di emulare.
Klopp, ad esempio, trasformò il gioco del Borussia Dortmund, riproponendo il calcio totale olandese con un nuovo nome: Gegenpressing, ovvero pressing immediato sul portatore di palla dopo la perdita del possesso.
Il calcio attuale è solo una variante del calcio impossibile olandese.
Poi ci fu il sistema Vianema, inventato da Gipo Viani: un misto tra catenaccio e contropiede, con l’invenzione del libero alle spalle della difesa. Molti altri allenatori hanno lasciato il segno: Rocco, Herrera, Bearzot, per citarne alcuni.
Indimenticabile anche Zeman, con il suo calcio ultra-offensivo ma con una difesa aperta come un’autostrada. Bagnoli e la sua semplicità portarono il Grifone in Europa negli anni ’90. Ma soprattutto Arrigo Sacchi, che, pur senza una grande carriera da giocatore o allenatore, arrivò a Milanello e mise in campo un 4-4-2 rivoluzionario. Un calcio totale, fatto di sovrapposizioni in tutti i ruoli, ispirato proprio a Michels.
E non si può dimenticare Gasperini. Non solo perché ha allenato il Genoa, ma perché nel 2006, vincendo il campionato di Serie B con il Grifone, riportò in vita il 3-4-3, schema abbandonato da molti. Non lo ha più lasciato. Oggi i sistemi più utilizzati sono il 4-2-3-1, il 3-5-2, il 4-3-3 e le varianti del 4-4-2.
Il 4-2-3-1 consente di usare giocatori con diverse caratteristiche davanti (punta, ali, trequartisti). Ma questi devono sapersi sacrificare nel pressing alto: una scelta che l’allenatore deve considerare attentamente.
Il 3-5-2 punta molto sull’intensità centrale, sia in difesa che a centrocampo. Il suo punto debole è se i quinti si abbassano troppo sulla linea difensiva: diventa difficile ripartire.
Il 4-3-3 sfrutta ampiezza e profondità, le catene di gioco e l’occupazione degli spazi in fase difensiva. Ma se non si riesce a invadere il centrocampo avversario con centrocampisti, terzini e ali, l’attacco perde efficacia.
È chiaro che la differenza non la fanno solo i moduli, ma i giocatori. Basta leggere le formazioni di Michels o Sacchi.
In ogni sistema è fondamentale il lavoro dei centrocampisti: da loro dipende se il gioco sarà più offensivo o difensivo. Importante anche il lavoro sulle corsie laterali, dove la corsa può contare più della qualità, dovendo coprire entrambe le fasi. Le cinque sostituzioni aiutano molto gli allenatori in questo.
Un efficace gioco di squadra non può basarsi solo su una specifica distribuzione degli uomini in campo. Tutto ha importanza, a condizione che sia coerente con le caratteristiche tecnico-tattiche dei giocatori a disposizione.